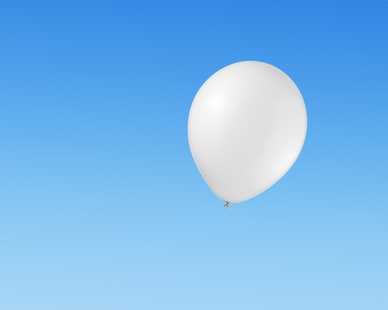Il post di oggi, concomitante con questo nuovo inizio anno scolastico, ha come tema un argomento del quale ci siamo già occupati, (Bullismo omofobico: risponde il dr. Jimmy Ciliberto), un fenomeno che, come detto, ha radici profonde ma che solo ultimamente è diventato un argomento dibattuto nelle cronache nazionali. Sto parlando di bullismo omofobico e questa attenzione testimonia finalmente una maggiore sensibilità dell’opinione pubblica su temi legati alla violenza omofobica. Abbiamo visto come il bullismo omofobico sia l’atteggiamento o il comportamento violento tramite il quale una persona viene presa di mira da un coetaneo (o da un gruppo di coetanei) in una relazione all’interno della quale il rapporto di potere non è paritario. La persona prescelta viene oppressa con vari atteggiamenti (derisione, minacce, insulti, esclusione…) ed il pretesto per l’attacco è dato, appunto, dalle scelte sessuali o dall’orientamento sessuale (reale o presunto) della vittima.
Per continuare a parlare di questo importante tema, ho pensato di rivolgermi ad un collega che, per professione, è un profondo conoscitore della materia. Mi riferisco a Federico Ferrari, psicologo, psicoterapeuta e autore, insieme ai colleghi Paolo Rigliano e Jimmy Ciliberto, del testo Curare i gay? Oltre l’ideologia riparativa dell’omosessualità, edito da Cortina. Federico dedica la sua attenzione e il suo impegno anche a tematiche legate all’orientamento sessuale e all’identità di genere. Chi volesse ulteriore dettagli sul libro citato può cliccare qui mentre chi volesse saperne di più sul dr. Ferrari può cliccare qui.
Ciao Federico, innanzitutto grazie per aver accettato l’invito e benvenuto! Direi di partire dalla definizione di bullismo omofobico: come potremo descriverlo?
Quando si parla di “bullismo” di solito ci si riferisce a relazioni tra pari (compagni, colleghi, etc.) nelle quali uno o più cercano di affermarsi agendo varie forme di violenza, ci possono essere allora una o più vittime, scelte per il fatto di essere facili da isolare dagli altri, non solo deboli, ma anche portatrici di caratteristiche che le rendono meno “popolari”, almeno secondo i bulli. Infatti in queste situazioni l’obiettivo del “bullo” è di affermare la propria forza di fronte ad un pubblico, attaccando qualcuno che in qualche modo possa meritare, agli stessi occhi del pubblico, la violenza che subisce. Spesso in realtà gli spettatori della violenza non intervengono per ben altri motivi, ma il loro silenzio alimenta la sensazione del bullo di apparire forte e quella della vittima di solitudine e disvalore. Per questo il bullismo omofobico, ossia agito su qualcuno per il fatto che è o appare omosessuale, non ha bisogno di contesti strettamente antiomosessuali per proliferare: è sufficiente che siano contesti, per così dire, “eterosessisti”, ovvero in cui l’omosessualità non è presa in considerazione, e non si afferma la necessità di difenderne il valore paritario rispetto all’eterosessualità. In molti ambienti, specie tra gli adolescenti, l’omosessualità è ancora qualcosa di cui non si parla se non come insulto, e questo ne fa una caratteristica catalizzante per i comportamenti di bullismo. Per il bullo probabilmente se non fosse l’omosessualità sarebbe qualcos’altro, perché si tratta di un individuo insicuro, scarsamente empatico, che cerca pretesti per affermarsi in modo facile e prepotente, ma le persone omosessuali (o che secondo gli stereotipi correnti lo sembrano) rappresentano un gruppo a rischio per il fenomeno del bullismo. Per altro ad oggi ci sarebbe un discorso a parte da fare sulle forme della violenza e le trasformazioni cui va incontro a fronte della massiccia diffusione dei social network e delle relazioni virtuali…
In base alla tua esperienza, è una realtà diffusa oppure un fenomeno di nicchia?
In generale si tratta di un fenomeno ampiamente sottovalutato: laddove è infatti più probabile che si verifichino episodi di bullismo omofobico è anche dove di solito si presta minore importanza alla tutela delle differenze di identità sessuale. Di conseguenza si genera un substrato specialmente fertile per questo tipo di fenomeno, e contemporaneamente si distoglie l’attenzione dai segnali di un suo possibile verificarsi. Oppure, quando si identifica, si tende ad attribuirlo ad altro. Per altro anche le modalità con cui questi atti si manifestano dipendono in parte dal contesto culturale: possiamo incontrare contesti “conservatori” in cui sono presi come bersaglio ragazze o ragazzi che hanno fatto il proprio coming out contro tutto e tutti, ma capitano anche contesti per così dire “liberali” in cui vengono vittimizzati ragazzi effeminati perché non si definiscono omosessuali, e l’etichetta con cui vengono stigmatizzati diventa quella del “gay che non si accetta” (del genere: “…dillo che sei gay!”). Spesso infatti le dinamiche sono più complesse di ciò che sembra, e chi è preso di mira lo è su tutta una serie di aspetti di “divergenza” dal gruppo, di cui l’omosessualità (o l’idea di essa) rappresenta solo una categoria esplicativa stigmatizzata/ante intorno alla quale si organizzano gli “insulti” e la “maldicenza” verso il diverso. Quello che davvero hanno però in comune questi contesti è di essere luoghi in cui non c’è spazio per la diversità e il rispetto dell’unicità, in cui la sessualità viene fagocitata dalla norma sociale rimanendo in bilico tra vergogna e vanità. In questi spazi il bullo agisce la sua violenza a partire dalle norme implicite, usandole come arma di umiliazione, e i suoi spettatori, nella più classica dinamica della “banalità del male”, gli danno ragione, o non riescono a trovare un torto sufficiente nella sua violenza per intervenire, perché significherebbe mettersi a loro volta contro delle regole che in parte condividono…
Cosa provocano questi attacchi alla persona colpita, e quali sono le reazioni più comuni a questo tipo di discriminazioni?
Naturalmente il bullismo può avere diversi livelli di gravità, ma chi ne è vittima può vivere l’inferno. In generale per la vittima ne scaturiscono sentimenti di profonda solitudine, umiliazione, ingiustizia e rabbia, che facilmente però possono evolvere in senso di impotenza e di disperazione. Si aggiunga a tutto ciò il fatto che, per la natura del fenomeno, chi di solito è scelto come vittima è anche qualcuno che in quel dato contesto si profila già come più fragile, magari solo perché l’ultimo arrivato, magari perché stigmatizzato, altre volte perché in difficoltà nei rapporti interpersonali, o in crisi rispetto a sé, o per tutte queste cose insieme. Si aggiunga che gay e lesbiche scoprono la propria omosessualità in un contesto che non la prevede, dopo aver passato i primi anni della propria vita senza prevederla nemmeno loro, e non di rado in adolescenza si trovano ad essere insicuri e combattuti su come gestire ed integrare nella propria identità questa nuova informazione su di sé. Ecco quindi che la vittimizzazione può trasformare un passaggio di crisi e di fatica personale in un’idea di sé senza speranza, in un senso d’indegnità traumatico, che mina la possibilità di trovare un valore di sé. Se poi pensiamo che l’omosessualità è ancora un tabù in molte famiglie, che i e le giovani omosessuali e bisessuali spesso non sentono la possibilità di parlare di questa parte di sé con i propri genitori, chiedere aiuto può diventare impossibile. Se dunque viene a mancare qualunque sostegno e il bullismo colpisce nell’indifferenza totale, il senso di disperazione può spingere anche a decisioni drastiche, nelle quali la richiesta di aiuto e la voglia di farsi del male non sono sempre distinguibili l’una dall’altra.
La maggior parte di questi episodi avviene durante la preadolescenza e l’adolescenza, età nelle quali i ragazzi sono per molto tempo a scuola. Prendiamo in considerazione come si comportano gli altri attori di questa istituzione: gli insegnanti come affrontano questi episodi?
E’ chiaramente difficile generalizzare. Molto dipende dalla competenza e dalla sensibilità dei singoli insegnanti, dalla loro formazione sui temi della discriminazione e dell’identità sessuale, ma anche dal loro modo di intendere il proprio ruolo di educatori. E su questo non basta davvero un generico impegno ad andare oltre la trasmissione di un sapere tecnico, per garantire le buone maniere ed il rispetto reciproco, è necessario farsi carico delle relazioni con i ragazzi.
Da un lato, è fondamentale la prevenzione perché in un contesto in cui i pari valorizzano il rispetto, la dinamica del bullismo non si sviluppa. Le occasionali uscite aggressive o violente vengono respinte da chi assiste. Coloro che maggiormente faticano a mettersi nei panni degli altri, e tendono a ricorrere alla prepotenza, hanno occasione di sperimentare strategie di autoaffermazione differenti e talvolta di apprendere l’empatia. Prendersi il tempo per coltivare con la classe i temi del confronto e del rispetto, farsi promotori di uno spazio in cui il valore della pluralità e della differenza si fanno parte integrante dell’insegnamento e del modo di stare a scuola non è semplice, perché significa creare una cornice di dialogo tra sistemi di valori diversi, in cui il rispetto della persona umana rappresenti una premessa irrinunciabile. Dobbiamo riconoscere che spesso le condizioni in cui gli insegnanti lavorano semplicemente non permettono un lavoro di questo respiro. Spesso questo tipo di intervento viene però attivato ai primi segnali di bullismo, quando il clima in classe comincia a farsi teso e difficile per alcuni, e ci sono state delle prime occasioni di violenza psicologica o fisica.
Dover lavorare sull’urgenza, e muoversi di fronte a casi di violenza conclamata è per molti versi già una sconfitta, ma è soprattutto estremamente complesso, richiedendo di tenere insieme più istanze, a volte anche opposte. Da un lato è fondamentale intercettare i segnali della violenza psicologica, o agita fuori dal campo visivo degli insegnanti, oltre che quella eventualmente palese ed agita in classe. Poi si tratta di creare lo spazio e il tempo adeguato perché la vittima si senta libera di denunciare la violenza, senza sentirsi ulteriormente stigmatizzata come “quello o quella che chiede la protezione dall’insegnante”. Dall’altro lato, è necessario attivarsi verso il bullo sanzionando tempestivamente i suoi comportamenti, assicurandosi che le regole che ogni istituto dovrebbe avere per casi di questo tipo, siano attuate senza se e senza ma. Tuttavia ogni intervento “contro il bullo”, se non si riesce ad attuarlo in una cornice di preoccupazione nei suoi confronti, evitando la caccia alle streghe, coinvolgendo sinergicamente la famiglia, è destinato a fallire, rafforzando ulteriormente le sue istanze di prepotenza: trasformare il bullo nel mostro psicopatico della situazione, umiliarlo perché impari a rispettare l’autorità, e altre sciocchezze simili non fanno che aggiungere violenza ad un contesto evidentemente già disfunzionale, rischiando di spostare la violenza ad altri spazi ed altri luoghi in cui alla fine esploderà, se possibile aumentata. Infine è necessario assodare il coinvolgimento della classe, capire il ruolo degli spettatori, e considerare i pro ed i contro di un intervento con loro, recuperare un’attività di prevenzione che è mancata in partenza.
Mentre le scuole come istituti che fanno?
Le scuole sempre di più sono chiamate a pensare il problema in anticipo, creare programmi di prevenzione e protocolli di azione. Una volta di più diviene fondamentale però che siano gli interventi preventivi ad avere la priorità. Creare occasioni di formazione continua per gli insegnanti su ogni forma di differenza, inclusa le differenze di identità sessuale. Solo maneggiando con maggiore confidenza questi temi, affrontando i propri stessi pregiudizi, recuperando i dati della scienza, gli insegnanti possono farsi promotori e mediatori di spazi di confronto e di dialogo tra gli studenti. Oggi, se possibile, è ancora più difficile per due ragioni. La prima, propria piuttosto di alcune realtà di frontiera, è che sono gli stessi insegnanti a sentirsi “bullizzati”: in contesti che ne sminuiscono la dignità e l’autorevolezza, e in cui un allievo violento può trovare nel resto della classe un pubblico supportivo ad uno scontro con i rappresentanti stessi di un’istituzione di cui la maggioranza del suo gruppo non capisce più il significato. In questi casi è il contesto istituzionale allargato che sta mancando nell’offrire senso e risorse ad intere fette di popolazione, alimentando una violenza diffusa che certamente finirà per trovare sfogo sui soggetti divergenti, quale che sia la caratteristica che li rende tali.
La seconda, più legata a certi contesti “conservatori”, è che sembra crescere il numero di quelli che considerano i propri valori come un “diritto alla discriminazione”. Questo lo abbiamo visto banalmente nel caso di progetti di educazione all’affettività, accusati di farsi promotori di una fantomatica “ideologia del genere” perché semplicemente incoraggiavano gli studenti a superare alcuni stereotipi sessuali, che sono provati essere alla base della violenza sulle donne e di quella omofobica. Quando questo modo di intendere i valori diviene dominante, l’insegnante può sentirsi incapacitato ad affermare la regola del rispetto proprio a causa del suo “mandato di rispetto dei valori di tutti”, o per timore di dover affrontare genitori che difendono il diritto dei figli ad esprimere idee omofobiche, o che contestano l’idea che l’insegnante intervenga sui valori insegnati in famiglia. In questi casi è fondamentale che la scuola (dal preside al ministro) sostenga gli insegnanti, perché non si trovino lasciati soli nell’affermare il proprio mandato educativo.
All’interno della famiglia, come pensi dovrebbero comportarsi i genitori dei ragazzi presi di mira?
Chiaramente la famiglia dovrebbe essere prima di tutto un luogo protettivo in cui non debbano ripetersi le dinamiche che hanno reso possibile il bullismo altrove. Un ragazzo gay o una ragazza lesbica o bisessuale devono poter parlare della propria identità sessuale, e quindi del fatto che questa è divenuta il pretesto per prenderli di mira. Diversamente, il rischio è che per paura di dover fare un coming out a casa, le vittime di bullismo non parlino delle prese in giro nemmeno con i propri genitori. Anche quando si tratti solo di una percepita omosessualità, se il ragazzo o la ragazza pensa che i propri genitori trovino la cosa sbagliata o vergognosa, possono provare vergogna nel dire di essere trattati come tale.
In secondo luogo quando il proprio figlio riferisce di essere vittima di bullismo è fondamentale attivarsi immediatamente, prima di tutto con la scuola, poi, se appare indicato dalle circostanze, con i genitori del bullo, in casi estremi con le forze dell’ordine. E’ importante avere determinazione senza alimentare un clima di scontro: l’obbiettivo è quello di garantire la sicurezza del ragazzo senza metterlo al centro di un conflitto tra fazioni. L’aspetto fondamentale, in ogni caso, è che il senso di solitudine venga spezzato, che i ragazzi sentano il supporto e la fiducia negli adulti. Poi può essere utile provare a lavorare con questi ragazzi sulle loro strategie interpersonali, per capire se nel contesto specifico queste risultino funzionali o se per qualche ragione li stiano predisponendo in modo particolare alle prevaricazioni dei prepotenti.
Mentre le famiglie dei bulli a cosa dovrebbero prestare attenzione?
Certamente a non sottovalutare i comportamenti del figlio, non etichettarli come “bravate” o “ragazzate”, che è poi un modo di non occuparsi di loro, di sminuire il problema ed in definitiva di non occuparsene. Il “bullo” ha molto bisogno della sua famiglia: ha bisogno di sapere che non ne perderà l’affetto per ciò che ha fatto, ma che ciò che ha fatto avrà delle conseguenze. Spesso manca un sistema etico di riferimento forte, dei modelli coerenti e affettivamente presenti in grado di trasmettere il senso del bene e del male. Talvolta, quando il “bullo” è parte di un “branco”, di un gruppo cioè in cui si è assistito ad una diffusione della responsabilità, e ciascuno si è sentito solo di andare dietro agli altri, ciò che è importante è aiutarlo a sviluppare la forza di opporsi agli altri quando viene passato un limite, nonché modi diversi di affermarsi nel gruppo, credere in sé, scoprire di avere qualità diverse e più importanti che non la capacità di attaccare ed umiliare gli altri.
Come possiamo collaborare per far si che episodi come questi diventino sempre più ostracizzati?
Mi vengono in mente due cose: offrire formazione per gli insegnanti e per i ragazzi spazio e tempo per imparare a confrontarsi, conoscersi e rispettarsi.
Un grazie di cuore a Federico per la disponibilità nell’essersi prestato alle mie domande. Il tema è vasto e ci torneremo ancora con altri interventi. Credo sia un ulteriore, importante passo per introdurre questo argomento in un dibattito che coinvolga più sedi possibili.
Se ci fossero persone interessate a testimoniare o a condividere la loro esperienza, naturalmente in forma assolutamente anonima (a meno che non desiderino il contrario!), possono contattarmi telefonicamente (3920008369) o per mail (fabrizioboninu@gmail.com).
Come sempre fatemi sapere che ne pensate.
A presto…
Fabrizio Boninu
Tutti i diritti riservati
 Naturalmente quello di cui sto parlando è un fenomeno particolarmente appariscente durante l’adolescenza, ma che in realtà interessa fasce di età sempre più ampie, spingendosi ben sopra la soglia dell’adolescenza. Non è infrequente venire a conoscenza di cinquantenni/sessantenni affetti dalla stessa smania digitale, persone per le quali il confine tra giorno e notte si è andato sempre più assottigliando in un presente continuo fatto di avvisi, notifiche e status. E noi stessi, se non siamo tra gli insonni, contribuiamo a questa continua massa di vampiri digitali, spedendo messaggi per i quali aspettiamo una rapida risposta, chiamando qualcuno pensando che non possa non rispondere, dando per scontato che l’altro sia li, immobile, disponibile e pronto a soddisfare qualunque nostro desiderio di contatto. Virtuale, si intende, che gli altri poi sono complicati.
Naturalmente quello di cui sto parlando è un fenomeno particolarmente appariscente durante l’adolescenza, ma che in realtà interessa fasce di età sempre più ampie, spingendosi ben sopra la soglia dell’adolescenza. Non è infrequente venire a conoscenza di cinquantenni/sessantenni affetti dalla stessa smania digitale, persone per le quali il confine tra giorno e notte si è andato sempre più assottigliando in un presente continuo fatto di avvisi, notifiche e status. E noi stessi, se non siamo tra gli insonni, contribuiamo a questa continua massa di vampiri digitali, spedendo messaggi per i quali aspettiamo una rapida risposta, chiamando qualcuno pensando che non possa non rispondere, dando per scontato che l’altro sia li, immobile, disponibile e pronto a soddisfare qualunque nostro desiderio di contatto. Virtuale, si intende, che gli altri poi sono complicati.